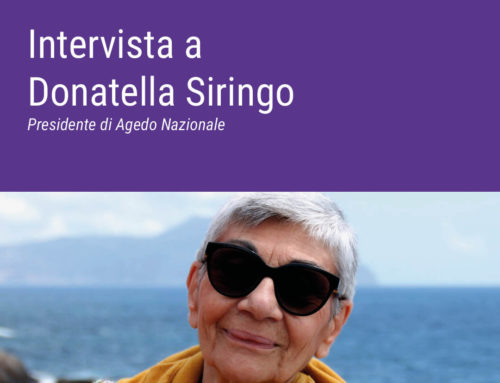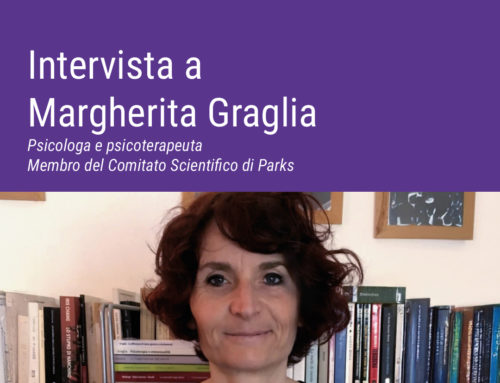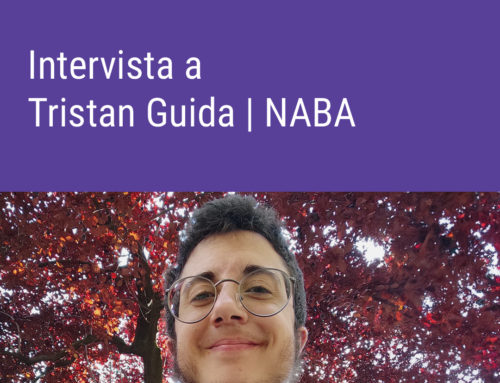Intervista ad Andrea Rubera. In occasione della Giornata mondiale del dialogo tra religioni e omosessualità, che ricorre il 13 gennaio di ogni anno, abbiamo chiesto ad Andrea Rubera di raccontarci il progetto dell’associazione Cammini di Speranza e di cosa vuol dire essere cattolici e appartenenti alla comunità LGBTQI+.
D – Sei il portavoce dell’associazione “Cammini di Speranza”, nata nel 2015 a Roma e la cui missione è quella di accogliere le persone LGBTQI+ di fede cattolica, col fine di – come scrivete sul vostro sito internet – “promuovere il rispetto, la dignità e l’uguaglianza delle persone LGBTQI+ nelle chiese e nella società”. Com’è nato questo progetto e quali sono le principali attività che portate avanti?
R – “Cammini di Speranza” è nata nel 2015 come unione di varie esperienze locali di cristiani LGBT+ presenti in Italia. Prima della nostra nascita, molte persone vivevano la propria fede e identità LGBT+ in modo frammentato e spesso isolato, cercando spazi di accoglienza nelle comunità locali, ma senza una rete nazionale. L’idea fondante era di creare un’associazione capace di dialogare a più livelli: con le chiese, con la società civile e con le istituzioni.
Oggi ci occupiamo di diverse attività. Il nostro approccio è ecumenico nel senso che fanno parte della nostra associazione diverse persone di confessioni diversa dalla cattolica, anche se la maggior parte, essendo in Italia, gravita intorno al mondo cattolico.
Collaboriamo anche con altre confessioni, in particolare con la chiesa valdese-metodista che supporta, con i fondi dell’8×1000 della Tavola Valdese, molti nostri progetti che vertono soprattutto sul tema della crescita delle comunità cristiane sui temi dell’inclusione delle persone LGBT+ attraverso la pubblicazione di libri, la valorizzazione del contributo dei cristiani LGBT+ negli anni, l’organizzazione di cicli di webinar o podcast per favorire la sensibilizzazione. Uno degli obiettivi è mostrare che la spiritualità e l’orientamento sessuale non sono in contrasto, ma anzi possono arricchirsi reciprocamente.
Vorrei citare due degli ultimi progetti che mi stanno più a cuore, entrambi realizzati con il contribuito dell’8×1000 della Tavola Valdese e Metodista: “Religo”, un web reportage fotografico realizzato con l’artista Simone Cerio che ha seguito per 5 anni i vari gruppi di cristiani LGBT+ e li ha raccontati con storie e immagini. Il lavoro è diventato poi un sito https://camminidisperanza.org/religo/ e una pubblicazione omonima. Poi il lavoro di ricerca “Credenti LGBT+: Diritti, fede e Chiese cristiane nell’Italia contemporanea”, affidato allo storico Matteo Mennini che ha raccolto materiali, documenti e la storia di 40 anni di cammino dei cristiani LGBT+ in Italia e lo ha trasformato per ora in una pubblicazione edita da Carocci. Il lavoro però evolverà in uno sito web che raccoglierà e organizzerà tutto il materiale documentale per non far disperdere un patrimonio fragile ma importante.
D – In passato, in alcune interviste, hai raccontato di come i gruppi di cristiani appartenenti alla comunità LGBTQI+ fossero oggetto di un doppio pregiudizio: da parte della Chiesa (proprio in quanto omosessuali o transgender), ma anche da parte della comunità LGBTQI+ laica. Ce ne vuoi parlare?
R – Essere persone LGBT+ credenti significa spesso trovarsi in una posizione difficile, esposti a un doppio pregiudizio. All’interno della Chiesa, molti di noi si sono sentiti esclusi, ignorati o giudicati a causa dell’orientamento sessuale o dell’identità di genere. Questo può portare a vivere un profondo senso di estraneità, un po’ come se fossimo sempre “ospiti” e mai completamente parte della comunità cristiana.
Dall’altra parte, nella comunità LGBT+ laica, si può percepire un certo scetticismo o incomprensione verso chi, nonostante il rifiuto istituzionale della Chiesa, sceglie di continuare a vivere la propria fede. Non sempre il nostro lavoro è compreso. A volte veniamo vissuti come “fiancheggiatori” di posizioni fondamentaliste, anche se questo non è vero.
Altre volte ci viene chiesto “chi ce lo fa fare” a rimanere dentro comunità che hanno una visione un po’ chiusa su omosessualità e identità di genere. La nostra posizione è che la fede è un po’ come la dimensione famigliare. Si può condividere o no cosa pensano i nostri genitori, sorelle o fratelli ma rimangono la nostra famiglia. Possiamo contribuire al cambiamento dell’opinione dei nostri famigliari ma solo partecipando dall’interno.
Siamo fermamente convinti che il cambiamento di contesti che sentiamo come “famiglia” possa partire solo dalla partecipazione e dalla testimonianza attiva.
Questa condizione ci ha spinti a creare spazi come quelli di “Cammini di Speranza”, dove poter da un lato vivere in modo autentico sia la fede che la propria identità dall’altro testimoniare in maniera attiva.
Ricordo però con piacere l’EuroPride 2011 che si svolse a Roma e che ospitò una rassegna specificatamente dedicata a fede e omosessualità: “Anime, avanzate!”. La organizzammo con la collaborazione di tante associazioni laiche all’interno della cittadella dell’EuroPride. Ospitammo John McNeill, uno dei fondatori della teologia queer e tante altre iniziative tra cui una mostra fotografica che raccontava il “Padre Nostro” secondo il vissuto di una persona LGBT+.
D – Come ha reagito la Chiesa al vostro progetto? Il dialogo tra questi due mondi è (stato) particolarmente difficile?
R – Il dialogo con la Chiesa è un percorso a ostacoli. Da un lato, ci sono state aperture significative: Papa Francesco ha mostrato un atteggiamento di ascolto verso le persone LGBTQI+, ricordando che ogni persona deve essere rispettata e amata come figlia di Dio e mettendo in primo piano la “persona” rispetto alla “dottrina”.
Spesso ha invitato i “pastori” a sentirsi addosso l’odore delle “pecore” e non a vivere lontani dalle persone. Dall’altro canto, le posizioni ufficiali del magistero restano spesso rigide, specialmente quando si parla di matrimonio, famiglia e ruoli di genere. Il cambiamento che sta proponendo la Chiesa di papa Francesco è un cambiamento senza strappi. Il tentativo è di portarsi appresso tutti e tutte nella Chiesa che, ricordo, è fatta di persone con provenienze culturali molto diverse: ad esempio dai vescovi tedeschi o belgi, che promuovono con decisione il tema delle benedizioni per le coppie LGBT+, a quelli di molti paesi africani che non riescono proprio ad accettare questo tema e minacciamo lo scisma se venissero obbligati a celebrare le benedizioni per le coppie LGBT+.
Questo porta a passi in avanti e altri indietro, come il pronunciamento della Congregazione per la Dottrina della Fede sulle benedizioni per le coppie LGBT+ che ha dovuto generare, poi, numerosi “distinguo” per non creare fratture con le diocesi più chiuse, come specificare che dovranno durare pochi secondi e non avvenire all’interno di liturgie ufficiali. Distinguo che ci appaiono come inutili e disturbanti se non letti nell’ottica del compromesso.
In Italia anche si sono fatti molti passi in avanti. Grazie alla prospettiva inedita avviata da papa Francesco si sono potuti avviare percorsi di confronto con alcune diocesi e parrocchie che stanno cercando di comprendere meglio le nostre esperienze. Cosa impensabile sino a pochi anni fa dove era esplicitamente negata l’accoglienza dei gruppi di cristiani LGBT+ nelle parrocchie e, quindi, dovevamo rivolgerci a chiese protestanti per essere accolti. Il dialogo è complicato ma ogni passo avanti, anche il più piccolo, ha un valore enorme.
D – Negli ultimi decenni si sta facendo strada un filone di studi che si può racchiudere sotto l’etichetta di “teologia queer”: ne fanno parte gli scritti del docente universitario John Robert McNeill (di cui ci hai parlato poco fa), ma anche, in Italia, di Michela Murgia (basti pensare al suo famoso saggio/pamphlet God Save the Queer). In cosa questa teologia differisce da quella “tradizionale”?
R – La teologia queer è un campo che nasce dall’esperienza di chi vive ai margini, unendo l’analisi teologica con le istanze di liberazione e inclusione delle persone LGBTQI+. John McNeill è stato uno dei padri fondatori di questo approccio. Il suo libro The Church and the Homosexual (1976) ha rappresentato una pietra miliare, sfidando l’idea che l’omosessualità fosse intrinsecamente peccaminosa. McNeill, da sacerdote gesuita poi divenuto laico e sposato con suo marito, ha vissuto in prima persona il conflitto tra obbedienza istituzionale e coscienza, scegliendo di stare dalla parte delle persone LGBTQI+.
In Italia, Michela Murgia ha dato un importante contributo divulgativo con il suo God Save the Queer, dove esplora il concetto di un Dio che abita le diversità e si rivela attraverso di esse. La teologia queer si distingue da quella tradizionale perché non parte da un’idea fissa di “norma”, ma accoglie la complessità delle esperienze umane, rileggendo le Scritture in chiave inclusiva. È una teologia che parla di liberazione, amore incondizionato e giustizia.
Per descrivere cosa significhi teologia queer, cito un ricordo di un episodio che ha riguardato uno dei nostri incontri a cui invitammo una teologa progressista molto famosa: Antonietta Potente che, ascoltando le nostre storie, rimase sorpresa e ci invitò in maniera molto diretta a partecipare attivamente senza attendere che qualcuno venisse a tenderci una mano; in questo modo rivendicava il nostro ruolo e il nostro diritto a essere lievito per una comunità cristiana che aveva bisogno anche del nostro contributo per crescere ed evolversi.
D – Ci potresti fare una panoramica delle associazioni religiose (non solo cattoliche) LGBT+ in Italia e in Europa?
R – In Italia, accanto a “Cammini di Speranza”, troviamo altre realtà nazionali e altre locali. Il primo gruppo locale a costituirsi è stato Il Guado di Milano, nato nel 1980. Oggi esistono circa 30 gruppi locali, alcuni composti da genitori cristiani con figli LGBT+, e 3 associazioni nazionali.
Dal 2007 un lavoro prezioso è fatto dai volontari che collaborano attraverso il portale Gionata.org. Quest’ultimo è una risorsa fondamentale per raccogliere testimonianze, organizzare eventi e condividere riflessioni spirituali. Il portale coordina da molti anni anche le veglie contro l’omotransfobia che vengono organizzate in molte città intorno alla data del 17 maggio.
A livello europeo, lo European Forum of LGBT Christian Groups, di cui Cammini di Speranza è socio, unisce associazioni di varj paesi europei e di varie confessioni cristiane, creando una piattaforma per promuovere inclusione e dialogo con le chiese. Momento centrale è la conferenza annuale che si svolge intorno ai primi giorni di maggio, ogni volta in un Paese diverso. Nel 2024 è stata ospitata in Italia. Ricordiamo che ci sono realtà come Acceptance in Polonia, che lavora in un contesto particolarmente ostile.
A livello mondiale, invece, esiste il Global Network of Rainbow Catholics, di cui Cammini di Speranza è socio fondatore, che promuove un dialogo specifico con la Chiesa Cattolica nelle varie diocesi mondiali.
Queste associazioni dimostrano che il cammino verso l’inclusione è globale e che, sebbene le sfide siano molte, esiste una rete di sostegno sempre più forte e articolata.